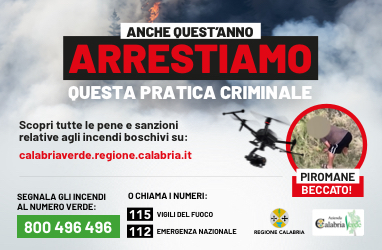Aumentano gli italiani che rinunciano a curarsi. Lo fanno perché le liste d’attesa sono troppo lunghe e perché non possono permettersi di rivolgersi alla sanità privata a pagamento. Nel 2024 sono stati 1,3 milioni in più dell’anno precedente coloro che si sono arresi: un segnale preoccupante perché avviene in un Paese in cui l’età media è molto alta. I dati sono stati illustrati dal presidente dell’Istat, Francesco Maria Chelli, nel corso dell’audizione alle commissioni riunite Bilancio di Senato e Camera per esaminare il testo della Finanziaria. I dati dell’Istat sono severi: nel 2024 il 9,9 per cento degli italiani ha desistito «per problemi legati alle liste d’attesa, alle difficoltà economiche e alla scomodità delle strutture». Significa 5,8 milioni di persone. Nel 2023 quella percentuale era più bassa (7,5 per cento) e ovviamente era meno rilevante il numero assoluto (4,5 milioni). Brutale sintesi: la situazione è in peggioramento e la causa principale della rinuncia a curarsi è rappresentata dalle liste d’attesa che viene indicata – spiega ancora l’Istat – «dal 6,8 per cento della popolazione». Le regioni del Nord – come Veneto, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia – restano sotto la media nazionale. Al Centro e al Sud, invece, le percentuali schizzano in alto: Sardegna al 17,2%, Abruzzo al 12,6%, Umbria al 12,2%, Lazio al 12%. Sopra la soglia del 10% si collocano anche Basilicata, Puglia, Calabria, Molise e Marche. Sorprendentemente, anche regioni ricche come la Lombardia (10,3%) e la Liguria (10,1%) superano la media nazionale, segno che la crisi dell’accesso alle cure è ormai un fenomeno diffuso.
Come è possibile? Eppure il governo ha stanziato più risorse per la sanità pubblica. Analisi dell’Istat (sulla spesa totale però, non sui fondi statali): «Nel 2024 la spesa sanitaria totale è pari a 185,1 miliardi di euro. La componente finanziata dal settore pubblico si attesta a 137,5 miliardi di euro, la spesa sostenuta dalle famiglie è di 41,3 miliardi». L’ultimo spicchio – 6,4 miliardi – passa in gran parte dalle assicurazioni private. Il Ministero dell’Economia ha ricordato che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui contribuisce lo Stato raggiungerà i 142,9 miliardi di euro nel 2026 (+6,4 miliardi rispetto al 2025), 143,9 nel 2027 e 144,8 nel 2028. Il ministro Giancarlo Giorgetti ha osservato: «Anche con questa manovra si stanziano nuove risorse per la sanità, pari a 2,4 miliardi nel 2026 e 2,65 miliardi a decorrere dal 2027». In audizione c’è stato il contributo del Cnel (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) che ha dato questa chiave di lettura: «Nonostante gli investimenti attivati con il PNRR, in particolare in innovazione tecnologica e rafforzamento dell’assistenza territoriale, secondo i dati più recenti la spesa sanitaria pubblica si manterrà attorno al 6,3 per cento del PIL nel 2024 per scendere progressivamente al 6 per cento nel 2028. Sebbene in termini assoluti essa cresca di circa 8 miliardi, il rapporto rispetto al PIL segnala un definanziamento». Infine, c’è l’analisi della Corte dei Conti: «L’aumento delle risorse consente di rispondere solo parzialmente agli interventi necessari per affrontare le criticità del settore nel cui ambito appaiono in crescita i costi per i contratti del personale, per i farmaci, per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati e per i dispositivi medici e, in generale, per corrispondere alle esigenze di una popolazione sempre più anziana». Ma come mai, nonostante la riforma del sistema delle liste d’attesa del Ministero della Salute, aumenta il numero degli italiani che rinunciano a curarsi perché non riesce a prenotare in tempi adeguati una visita o un esame e al contempo non può permettersi di farlo a pagamento?
Prima di tutto, i dati sono del 2024: ancora la riforma delle liste d’attesa non era operativa. Nel 2025 ci sono segnali di miglioramento, «ma a macchia di leopardo, a volte con differenze nella stessa regione da asl ad asl», osserva Valeria Fava, responsabile della Salute per Cittadinanzattiva. Ma c’è un macigno che pesa più di altri ed è sempre l’Istat a segnalarlo: non ci sono sufficienti medici e infermieri. E quelli ancora in servizio spesso sono vicini alla pensione. Assumerne di nuovi non è semplice, perché mancano proprio le professionalità (nel caso degli infermieri) o perché una quota dei giovani preferisce lavorare nella sanità privata o andare all’estero (i medici). Spiega l’Istat: «A fronte di un aumento della domanda di cure dovuto all’invecchiamento della popolazione, nel contesto internazionale l’Italia si connota per uno scarso ricambio generazionale per il personale medico e una dotazione insufficiente di quello infermieristico. Nel 2023 si registra la quota più alta tra i Paesi dell’Ue di medici anziani in servizio: il 44,2% ha più di 55 anni e il 20,6% supera i 65 anni; per quest’ultima fascia di età, valori decisamente più bassi si osservano in Francia (16,1%), Germania (9,4%) e Spagna (8,4%)».
Sui medici di base, l’analisi è impietosa: «Attualmente sono 37.983, 0,64 per mille residenti. Il 60% ha almeno 60 anni. In un contesto in cui la dotazione è decrescente (-7.220 medici in dieci anni), desta particolare preoccupazione l’uscita dal mercato del lavoro di molti professionisti e il conseguente ulteriore incremento del carico di assistenza per chi continua a svolgere questa attività professionale: la percentuale di chi ha più di 1.500 assistiti (valore massimo stabilito dalla normativa) è pari al 51,7%, in aumento di 4 punti percentuali rispetto al 2022». Non va meglio sul fronte degli infermieri: sono 405mila, 6,9 ogni mille abitanti (la media dell’Ue è di 8,3). Un infermiere su 4 ha più di 55 anni.