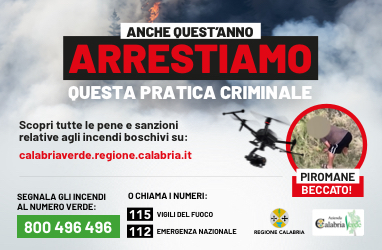(Adnkronos) – All'indomani del voto per le regionali la politica sembra accelerare sulla riapertura del cantiere della legge elettorale. Tema che caratterizza da tempo il dibattito parlamentare, anche alla luce delle riforme costituzionali su cui la maggioranza sta lavorando, a partire dal premierato legato a doppio filo alla necessità di un nuovo sistema di voto 'compatibile' con l'elezione diretta del presidente del Consiglio, prevista nel testo di riforma. Il quadro delle leggi elettorali in vigore, su cui intendono intervenire i legislatori, presenta ad oggi una serie di norme diverse, che regolano le modalità di scelta di parlamentari, amministratori locali – dai governatori ai sindaci – e degli eurodeputati. Meccanismi che sono cambiati con frequenza nel tempo, e che oggi presentano sistemi che vanno dal proporzionale, al maggioritario, per lo più prevedendo sistemi misti. Per le elezioni politiche, quelle per la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, il sistema attualmente in vigore è un sistema ibrido, prevalentemente proporzionale con correttivo maggioritario, noto come 'Rosatellum' (Legge n. 165/2017). Un sistema che rispetto al Mattarellum, in vigore in Italia dal 1993 al 2005, appare capovolto: la legge che porta il nome dell'attuale capo dello Stato era infatti prevalentemente maggioritaria, con preponderanza della componente uninominale, che valeva il 75% dei seggi. Tra Rosatellum e Mattarellum, trovò spazio un ritorno 'corretto' al proporzionale, sistema che era stato utilizzato per i primi quarant'anni della Repubblica. E' la legge Caderoli del 2005, o 'Porcellum', che istituiva un sistema proporzionale con un premio di maggioranza molto consistente, diverso tra Camera e Senato, e soglia di sbarramento al 4% per i partiti e al 10 per le coalizioni. Il Porcellum prevedeva infine liste bloccate, senza preferenze. Rosatellum. Il Rosatellum prevede l'assegnazione di 3/8 dei seggi (147 alla Camera e 74 al Senato comprensivi dei seggi della Valle d’Aosta e del Trentino Alto-Adige) con metodo maggioritario, in collegi uninominali. L'assegnazione dei restanti 5/8 dei seggi (245 seggi alla Camera e 122 seggi al Senato) avviene con metodo proporzionale, in collegi plurinominali, tra le liste e le coalizioni di liste che abbiano superato le soglie di sbarramento. Per il Senato, le circoscrizioni elettorali sono 20, coincidenti con il territorio delle regioni. Per la Camera dei deputati, le circoscrizioni sono 28, inclusa la Valle d’Aosta. Ciascuna circoscrizione è, a sua volta, suddivisa in collegi uninominali ed in collegi plurinominali. Per il Senato sono previsti un numero di collegi uninominali pari appunto ai 3/8 del totale dei seggi da eleggere, che oggi sono in totale 74 (su 196). Alla Camera i collegi uninominali sono invece 147 (su 392). Ciascun elettore dispone di un voto per la Camera e di uno per il Senato, da esprimere su un’unica scheda, recante il nome del candidato nel collegio uninominale, il contrassegno di ciascuna lista o, nel caso di liste collegate in coalizione, i contrassegni di tali liste, con a fianco i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale (da due a quattro). Sono proclamati eletti, per la parte proporzionale, i candidati della lista del collegio plurinominale secondo l’ordine di presentazione, nel limite dei seggi cui la lista abbia diritto. Per la parte maggioritaria del voto delle politiche, è proclamato eletto il candidato con più preferenze in ciascun collegio uninominale. Il restante 2 per cento di seggi (8 deputati e 4 senatori) viene 'riservato' al voto degli italiani residenti all'estero, in questo caso attraverso il proporzionale. Previste infine soglie di sbarramento: le liste singole devono superare la soglia del 3% a livello nazionale per accedere alla ripartizione proporzionale dei seggi (salvo eccezioni per le minoranze linguistiche). Le coalizioni devono superare la soglia del 10%. Regionali – Diversi i sistemi per eleggere i consiglieri regionali e i presidenti di Regione. Il modello varia da regione a regione, ma generalmente prevede un sistema proporzionale con un premio di maggioranza per garantire la governabilità e l'elezione diretta del presidente della giunta regionale. In alcune realtà è previsto il ricorso al voto disgiunto, come avvenuto nell'ultima tornata appena terminata in Veneto, ovvero la possibilità di votare un candidato presidente e una lista a lui non collegata. Sempre restando al modello Veneto, gli elettori, come in gran parte delle altre regioni, si esprimono in un turno unico, senza possibilità di ballottaggio, attribuendo infine un premio di maggioranza alla coalizione uscita vincente. Comunali – Per le elezioni dei sindaci, gli italiani cambiano sistema in base alla popolazione dei comune al voto: in quelli con più di 15mila abitanti, per l'elezione del primo cittadino si applica un sistema maggioritario a doppio turno, con il ballottaggio finale, qualora nessuno dei candidati ottenga la maggioranza assoluta al primo turno. Anche nei comuni popolosi è previsto un premio di maggioranza per la lista o coalizione collegata al sindaco eletto. Nei comuni con meno di 15mila abitanti, il sindaco è invece eletto con un sistema maggioritario a turno unico: chi ha più voti diventa primo cittadino. Elezioni Europee – Infine le elezioni europee, che si tengono ogni 5 anni, prevedono un sistema elettorale proporzionale con soglia di sbarramento del 4% e possibilità di voto di preferenza. I seggi sono assegnati nel collegio unico nazionale, a liste concorrenti presentate nell’ambito di 5 circoscrizioni molto ampie.
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Legge elettorale, riparte cantiere per riforma: da Rosatellum a proporzionale i sistemi vigenti
ULTIME NOTIZIE
Meloni rilancia l’azione del governo e attacca le toghe: “Vanificano il...
(Adnkronos) - Sicurezza e giustizia, con lo sguardo rivolto al prossimo referendum. Ma...