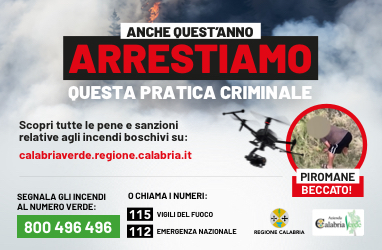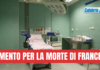Il Ponte sullo Stretto, per come è progettato oggi, potrebbe non reggere un terremoto simile a quello dell’Aquila del 2009 o di Amatrice del 2016. Anche se la magnitudo dei due sismi recenti è stata rispettivamente di 6.3 e 6, ben più bassa della 7.1 che caratterizzò secondo le ricostruzioni il terremoto di Messina del 1908, il Ponte potrebbe essere troppo debole per resistervi. Il progetto infatti sta probabilmente sottostimando un valore che ancor più della magnitudo è in grado di predire se una struttura resisterà a una scossa oppure crollerà. “La magnitudo misura la forza, quindi l’energia di un terremoto. Ma ciò che crea i danni agli edifici è lo scuotimento del terreno” spiega Carlo Doglioni, che da un mese ha esaurito i suoi due mandati da presidente dell’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. “Questo valore viene misurato sotto forma di accelerazione massima del suolo al momento della scossa. All’Aquila o ad Amatrice si sono raggiunti valori vicini all’accelerazione di gravità. Il progetto attuale del Ponte invece prevede che le torri e gli ancoraggi delle funi resistano a un valore che è solo il 58% dell’accelerazione di gravità: più basso di quel che abbiamo misurato in molte scosse recenti in Italia e nel mondo”. Doglioni è stato invitato a parlare venerdì a Messina dall’associazione “Invece del Ponte”, critica nei confronti del progetto. A lui è affidato il compito di evidenziare gli aspetti della geologia dello Stretto ancora non chiariti a sufficienza. L’accelerazione del suolo in caso di sisma è uno dei principali.
“Il valore del 58% della forza di gravità, o 0,58 g, è stato utilizzato come come valore di accelerazione del progetto. Rispetta le norme tecniche di costruzione, che mantengono però valori troppo bassi rispetto a quanto misurato negli ultimi due decenni grazie all’aggiunta di nuove stazioni sismiche e all’arricchimento delle reti accelerometriche in Italia e nel mondo”.
“La pericolosità sismica, misurata partendo dalle accelerazioni del suolo, viene calcolata soprattutto sulla base del catalogo della storia dei terremoti di una data regione, che è inevitabilmente lacunosa perché la tettonica ha tempi che possono essere di secoli o millenni. Viene usata per rispondere alla domanda: se guardiamo ai terremoti del passato, che probabilità abbiamo che nell’area dello Stretto si ripeta una scossa forte per esempio come quella del 1908?”
Per un’infrastruttura considerata strategica come il Ponte si è calcolato in particolare qual è l’accelerazione del suolo che ha una probabilità superiore al 2% di verificarsi nei prossimi duecento anni. Questo tipo di calcolo si chiama probabilistico. “Abbiamo visto – spiega ancora Doglioni – che può sottostimare molto le accelerazioni del suolo nell’area dell’epicentro, dove avvengono gli scuotimenti maggiori e quindi i danni più gravi alle abitazioni e alle infrastrutture. Quest’area per terremoti di magnitudo tra 6 e 7 può superare ampiamente i 1000 chilometri quadrati”.
“Nel mondo, se per esempio si vuole costruire un’infrastruttura critica come una centrale nucleare, si fa un altro tipo di ragionamento. Ci si chiede: qual è l’accelerazione massima che possiamo aspettarci, in base alle nostre conoscenze della geologia e delle faglie attive?” Questo calcolo si chiama deterministico o di scenario e dà valori di accelerazione massima del suolo nettamente superiori rispetto al calcolo probabilistico. Costringe legislatori e ingegneri a lavorare con regole più severe. “Ma ha più senso, se si vuole che gli edifici restino in piedi”, sottolinea l’ex presidente dell’Ingv.
“Il terremoto in Turchia del febbraio 2023 ha raggiunto 2 g con una magnitudo di 7.7. Stessa accelerazione si è registrata per il 7.6 in Giappone del primo gennaio 2024. A L’Aquila si è arrivato a poco meno di 1 g con magnitudo 6.3, leggermente più del valore di Amatrice. A Taiwan lo scorso 20 gennaio è bastata una magnitudo 6 per raggiungere i 2,15 g”. La profondità dell’ipocentro e la composizione del suolo possono infatti amplificare l’accelerazione. Meno un terreno è solido, più le onde sismiche rallentano e aumentano la loro ampiezza, causando più danni rispetto ai suoli rigidi. Ai Campi Flegrei la scossa 4.4 dello scorso 13 marzo, sorprendendo molti, ha fatto superare di poco il valore di 1 g in un’area per fortuna ristretta.
“Anche le torri e gli ancoraggi del Ponte poggiano su un terreno povero dal punto di vista geotecnico, soggetto a possibili fenomeni di liquefazione” ricorda il geologo. L’esistenza di faglie attive nello Stretto, aggiunge Doglioni, “è documentata dal catalogo dell’Ispra, che è un ente dello Stato”. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, elenca nel database Ithaca tutte le faglie attive d’Italia cosiddette “capaci”: in grado cioè di provocare terremoti e rompere anche la superficie terrestre.
Nell’area dello Stretto ne compaiono due, quella di Cannitello (considerata responsabile del terremoto da centomila morti del 1908) e quella di Pezzo. La società Stretto di Messina spa ritiene però quel catalogo solo indicativo. Preferisce prenderne in considerazione un altro, il Diss (Database of Individual Seismogenic Sources), che non considera le due faglie attive e capaci.
“Il dibattito scientifico è aperto” spiega Doglioni. “Ma tra Calabria e Sicilia registriamo un allargamento dello Stretto di 3 millimetri all’anno nello spazio di 3 chilometri di mare, che per l’Italia è un valore molto elevato. Per fare un confronto, nell’Italia centrale tra il Tirreno e L’Aquila l’estensione è di 4 millimetri all’anno distribuiti su una distanza di più di cento chilometri. Il fondale dello Stretto si abbassa contemporaneamente di 1 mm all’anno. Tra il 1985 e il 2024 infine l’Ingv ha registrato 6.174 scosse nel raggio di 30 chilometri da Villa San Giovanni. Cosa può averle generate, se non delle faglie attive?”
(Fonte: repubblica.it)